Per quindici giorni ci siamo improvvisati intenditori di pallavolo, abbiamo disquisito di lotta libera, ci siamo appassionati al tiro a segno. È il bello delle Olimpiadi, un mondo utopistico dove ogni sport ha il posto che gli spetta, ma lo spazio dedicato alla pallacanestro rischia di tracimare a colpi di atleti plurimilionari, poco dediti allo spirito decoubertiniano, che si accattivano le telecamere e riempiono i sedicimila seggiolini della Carioca Arena.
Se il vostro cuore, come il nostro, rimbalza al ritmo di un pallone arancione sul parquet non avrete fatto gli schizzinosi e vi sarete sintonizzati sulla finale di domenica sera. Team USA che compiva il proprio destino e dilagava su un’onesta Serbia, 96-66.
Battezzati nell’unica fede del basket NBA, appassionati equanimi, crociati al servizio della superiorità tecnica e morale della pallacanestro europea: non importa a quale categoria apparteniate, la verità del campo mette tutti d’accordo – o almeno, ci prova.
Racconta che gli Stati Uniti hanno vinto la terza medaglia d’oro consecutiva, hanno coronato il decennio di Mike Krzyzewski con il successo numero 88 a fronte di una sola sconfitta (Giappone 2006, semifinale con la Grecia), hanno dominato un torneo competitivo senza nemmeno ingranare le marce più alte.
Dopo dieci anni persino i più agguerriti avvocati del “sì, però” iniziano a perdere la voce. Team USA non ha giocato bene, ricorrono in appello i più ostinati.
Vero, sacrosanto, se si identifica il bene con il bello o con l’emozionante; con la fluida circolazione di palla (quella dell’Australia inceppatasi – coincidenza? – sul più bello), con i cojones di Andres Nocioni che firma con 37 punti l’elogio funebre della Generaciòn Dorada.
Ma non serve consultare antichi trattati militari cinesi per realizzare che, in termini di agone sportivo, la massima espressione di bellezza è quella che conduce alla vittoria. A Coach K sta bene così. A Gregg Popovich, in cabina di pilotaggio dall’estate prossima? Vedremo.
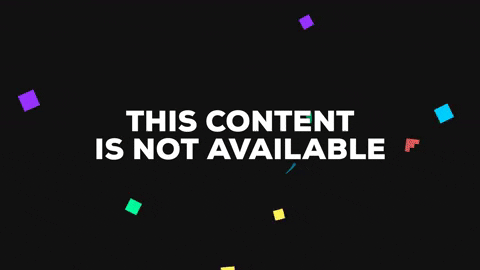
A volte sembra che Team USA pratichi un altro sport
Qualche sussurro si era sollevato nella noia del girone eliminatorio. Le vittorie, più risicate del previsto, contro Australia e Serbia fanno scattare un campanello d’allarme. Battere Team USA è possibile, coi giusti ingredienti in dosi letali.
Attacchi intelligenti per liberarsi sul perimetro, percentuali non inferiori al 50%, qualche sortita nel pitturato per facili appoggi prima che i lunghi recuperino. Difesa intensa, maschia, magari un po’ di mani addosso che non fanno mai male in pieno strong-style europeo – i Boomers se ne sono dimostrati ottimi interpreti, pur provenendo dall’emisfero australe. Shakerare e servire con ghiaccio, poi ripetere per quaranta minuti, senza interruzioni.
Il fatto è che gli Stati Uniti in quelle due partite giocavano col freno a mano tirato e la retromarcia inserita. Nella fase finale passeggiano con l’Argentina, superano la Spagna, demoliscono la Serbia.
Giocano male, si diceva. L’attacco si esalta sugli occasionali contropiede e su rare sequenze di extra-pass, ma per il resto è un fiorire di isolamenti in un quarto di campo, tiri malconsigliati a azione appena avviata, scorribande al ferro che si concludono in bizzarre carambole per via della difesa ruvida a cui gli attaccanti a stelle e strisce non sono abituati.

Questa l’ho già vista da qualche parte. No, non era la finale di serie A2 Regionale UISP
Spesso i primi quarti finiscono in equilibrio, come contro la Serbia e persino col modesto Venezuela, poi per svoltare la partita basta una parola. Effort.
Non è una spinta cieca, è l’impegno direzionato da Coach K verso quei frangenti che fanno la differenza.
I rimbalzi: li catturano in difesa, in attacco, di pura verticalità, statici coi lunghi e in corsa con gli esterni. Jordan ne colleziona 16 in 27 minuti contro la Spagna, Cousins lo imita in finale. +12 e +21, rispettivamente, il computo di squadra.
La difesa: rimediano alla poca disciplina con un attaccamento tignoso alla palla, compiono imboscate sulle linee di passaggio che condannano al turnover qualsiasi tentativo di skip pass, riempiono l’area, proteggono il ferro.
La mano di Mike Krzyzewski si vede poco su un team di campioni affermati, che a tratti giocano come fossero all’All Star Game, non è un caso se lascia in panchina le sue armi tattiche (Draymond Green, dove sei?), non azzarda la small ball e non impegna il suo playmaker d’elezione, Kyrie Irving, in un ruolo da regista. Non ne ha bisogno.
È una squadra che può veramente correre dietro agli avversari, spiegava in un’intervista per motivare le convocazioni. Ha il mirino puntato sulla difesa e sa come ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Il quintetto giusto per ogni occasione.
DeAndre Jordan preferito a Cousins alla palla a due, richiede meno attenzioni dai compagni; tanti minuti, un po’ inaspettati, agli uomini d’ordine Kyle Lowry e Jimmy Butler, Klay Thompson ondivago al tiro ma sempre sul pezzo nella propria metà campo; Carmelo Anthony sacrificato da 4 e Kevin Durant con licenza di uccidere; Paul George concentratissimo, trait d’union tra difesa e attacco.
È lui a soffocare l’offensiva serba in finale, su precisa indicazione del coach; si prende cura di Teodosic e lo inghiotte, gli altri limitano Bogdanovic. La più pacifica delle vittorie passa anche da una visione tattica corretta; quando poi disponi di tali interpreti per metterla in atto, non c’è spazio per contromosse.

Il tuo 2.13 di fiducia
Rio 2016 è stata l’ultima Olimpiade di Carmelo Anthony. Lascia come cestista più titolato e come miglior realizzatore di Team USA, in attesa di passare il testimone a Kevin Durant se avrà voglia di sposare ancora il progetto di Jerry Colangelo. Ci sono tutti i presupposti perché sia così, tira una bella aria intorno alla nazionale americana di basket.
Non saranno capaci di trovare una perfetta coesione in campo in un mese di allenamenti, ma fa un certo effetto vedere teste calde come Cousins o Jordan dedicare la loro estate a Team USA, o un ego ingombrante come quello di Draymond Green che si accomoda in panchina senza fiatare, raggiante come i compagni alla sirena finale.
La commozione di Carmelo, mentre ricorda quanto sia fiero di rappresentare il proprio paese nel post-partita, parla chiaro, così come i ripensamenti di LeBron James che invidia i colleghi olimpici e si arruffiana già in vista di Tokyo 2020: Coach K e Coach Pop sono i suoi due preferiti di sempre, sarebbe felice di essere allenato anche dal secondo.

In Brasile i canestri sono più bassi, o sei solo contento di vedermi?
Torna in mente un discorso già emerso nel corso del torneo, sul valore crescente che la medaglia olimpica va acquistando agli occhi dei giocatori. Forse, in una NBA ingabbiata da contratti, interessi e manovre di mercato, coronarsi il capo d’alloro tra i migliori dodici cestisti della propria nazione ha un sapore più dolce del mettersi al dito l’anello dei campioni. Quantomeno, diverso.
Kevin Durant il secondo vorrebbe ancora sperimentarlo, e ha ammesso di aver vissuto le Olimpiadi come una terapia dopo la turbolenta free agency; è sceso sul parquet senza sentirsi giudicato per la maglia che ha scelto di indossare.
Tutto questo per dire che l’orizzonte delle avversarie è inevitabilmente nero di pioggia? Non proprio.
In un torneo che ha vissuto di alti e bassi, si è assistito a un livellamento in direzione della massima qualità. È quello a cui aspira lo stesso Colangelo; interrogato se alla prossima occasione si presenteranno a giocare in quattro, ha risposto che dovranno essere gli altri a colmare il gap.
Riconosce che il movimento di Team USA ha fatto molto più che conquistare medaglie; ha posto sullo stesso piano il mondo dorato della NBA e la pallacanestro più sobria del resto del mondo, non più spettatori ma avversari, li ha motivati a fare ogni volta di meglio, ha aperto la strada a nidiate di internationals che popolano il basket americano già a livello collegiale.
A Rio si è ammirata una solida Australia ancora in attesa dei suoi giovani rampanti, insieme all’identità adamantina della Serbia di Djordjevic. Ma la strada per sconfiggere Team USA la mostra ancora la Spagna; un altro ciclo che probabilmente finisce, anche se con meno lacrimoni di quello argentino, e l’ennesima sfida con gli americani, a testa alta e a viso aperto, senza macchinazioni o sotterfugi.
Superarli in tecnica, pareggiarli – o quantomeno limitarli – in atletismo. Batterli al loro stesso gioco, perchè loro non si adattano a farne un altro, pur costretti nelle regole FIBA.
Un duello che dura da dieci anni e che non ha mai sorriso agli spagnoli, ancora in attesa della partita perfetta, ma che ci ha egregiamente intrattenuto nella vera finale del torneo. Noi aspettiamo che si ripeta tra quattro anni con altre facce, altre maglie, altri nomi.
Scrittore e giornalista in erba – nel senso che la mia carriera è fumosa -, seguo la NBA dall’ultimo All Star Game di Michael Jordan. Ci ho messo lo stesso tempo a imparare metà delle regole del football.


Ciao Andrea, Come stai?
Ti faccio i complimenti per il tuo meraviglioso articolo.
Voglio fare alcuni appunti:
1) Io credo che il problema di Team Usa sia anche il fatto che cambiano ogni volta il quintetto titolare, impedendo una certa chimica di squadra, mentre nel Team Usa femminile questo non succede (oltre al fatto che al femminile partecipano quasi sempre le migliori giocatrici)!
2) So che tu dissenti da me su questo, ma io non mi sono particolarmente invaghito nè di Sergio Lull, nè di Alex Abrines, nè di Ricky Rubio, nè di Willy Hernangomez i quali ritengo siano buoni giocatori ma non li vedrei mai come fuoriclasse in NBA, perciò il ricambio generazionale della Spagna non mi sembra così valido e non credo potranno essere più competitivi come lo sono stati finora.
3) Il ricambio generazionale dell’Argentina, invece, mi pare del tutto inesistente.
Ciao Anrea.
Ciao, grazie dei complimenti! Sulla differenza tra Team USA maschile e femminile sono d’accordo con te, ma non è detto che avere un quintetto “stabile” sia per forza preferibile. Dipende dalle idee dei singoli coach a mio parere. Sul futuro di Argentina e Spagna nessuno dei due è roseo come, per dire, quello dell’Australia. Col movimento che hanno dietro gli spagnoli, però, scommetto che vedremo comunque qualcosa di buono, magari con qualche anno in più di attesa.