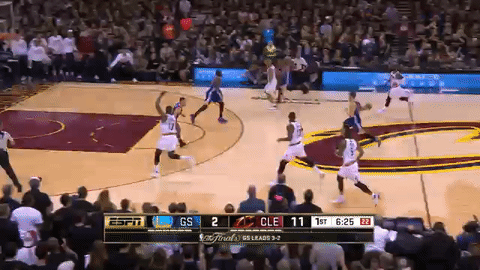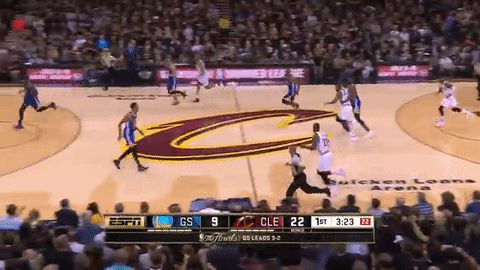Viene la pelle d’oca solo a pensare all’aria elettrica di Oakland in questo momento, una cappa mista di tensione, confusione e un pizzico di isteria che aleggerà sopra i grattacieli fino almeno a domenica notte, non diversamente dalla nebbia che è solita indugiare sul Golden Gate Bridge.
Capisci che sta succedendo qualcosa di storico quando la squadra che ha dominato la regular season più vincente di sempre, che ha sminuzzato un record dietro l’altro neanche avesse i coltelli dello Chef Tony, si presenta ai microfoni del post gara 6 con le facce da reduci del Vietnam e le mani che, per la prima volta, tremano.
Non per l’impazienza di stringere il Larry O’Brien Trophy, anche se a un certo punto avevano creduto che gli spettasse di diritto, ma per la paura di vederselo sfuggire sul più bello.
Nelle dichiarazioni che concedono ai media c’è la voce di chi ha perso la bussola e con essa quello swag che accompagna i Warriors da due anni, che non vede l’ora di tornare a casa per schiarirsi le idee.
“Questa squadra ha una buona prospettiva di gara 7” filosofeggia Steve Kerr. “Da un lato, è tutto quello per cui hai lavorato. Dall’altro, è solo una partita di pallacanestro”.
“Se all’inizio della stagione ti dicessero che ti giocherai l’ultima sfida delle Finals in casa” ha aggiunto, col contatore delle bugie che frullava oltre le decine, “ci metterei la firma”.
Stephen Curry afferma che i suoi Warriors sono forti dal punto di vista mentale e non bastano due partite storte a insinuare il seme del dubbio; pochi minuti prima aveva collezionato la prima espulsione della carriera rischiando grosso per il lancio del paradenti in prima fila. Se lui sostiene di non aver perso la calma, gli crediamo; la moglie Ayesha è un po’ meno convincente e questa cosa di Twitter le sta sfuggendo di mano.
Tra i membri della banda Klay Thompson sembra il più onesto, quello che dà pane al pane e vino al vino. Talk the talk, walk the walk, come dicono oltre la pozza. Gli chiedono se considererà la stagione un fallimento dopo un’eventuale sconfitta in gara 7. Ci pensa su, crede che sia una domanda a trabocchetto. Poi fa sì con la testa. Al 100%. “It’s either win the whole thing or bust for us”.
Eventuale sconfitta in gara 7? Bizzarro che se ne stia anche solo parlando. Se c’è una statistica che l’appassionato di NBA medio ha imparato a memoria nella settimana scorsa è che nessuna squadra ha mai rimontato un 3-1 nelle Finals.
C’è di più; gli ultimi a conquistare il titolo da corsari in gara 7 furono i Washington Bullets sui Seattle Supersonics nel 1978. Cos’è successo in gara 6 da spingere il mondo della palla a spicchi a considerare seriamente un’ipotesi tanto audace quanto inedita?
È successo LeBron James, LeBron James e ancora LeBron James. Lo stesso che nel post partita, interpellato da un floreale Craig Sager, ha sfoderato un “records are meant to be broken” con annesso sorriso a trentadue denti. Banalotta questa, Bron Bron, ma te la perdoniamo.
La misura del suo dominio sulla partita sta in quegli ultimi tre minuti del terzo quarto; ha bisogno di tirare il fiato ma non torna in panchina, piuttosto addormenta l’attacco in una serie di possessi scellerati, coi Warriors che ringraziano e prendono di mira la singola cifra di svantaggio.
Lui non batte ciglio; l’intervallo e un time out sono sufficienti, riprende a modellare la partita secondo i suoi gusti e ricaccia indietro Golden State. Segna 18 punti consecutivi per la sua squadra, molti dei quali sembrano depositarsi in fondo alla retina spinti dalla versione cestistica del primo motore aristotelico.
Certe manifestazioni di superiorità sono imbarazzanti per chi vi assiste, figuriamoci per chi le subisce. Esibirne tre di fila potrebbe rivelarsi troppo persino per lui, ma è il passo – da gigante – che manca per scrivere un altro capitolo nella sua storia, il più importante.
LeBron James leads everyone in everything … literally pic.twitter.com/gvhXehdaDV
— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 17, 2016
Non si è taciuto sui passati demeriti di Cleveland, similmente non se ne ometteranno le lodi. C’è più del prescelto sul parquet della Quicken Loans Arena.
C’è un attento studio per portare Tristan Thompson a incidere vicino a canestro con le giuste spaziature (15 punti senza errori al tiro conditi da 16 rimbalzi su 30 opportunità generate), ci sono gli 1vs1 selezionati per Kyrie Irving, c’è un coach un po’ lento a cambiare idea ma coraggioso, che panchina Kevin Love e fa girare i suoi a un ritmo più alto della gara precedente; 97.42 di pace e 121 di Offensive rating, 60% di canestri preceduti da un assist.
I Warriors però non sono gli stessi dopo che il treno chiamato LeBron li travolge nel primo quarto. Il pace and space non ingrana (42% di canestri non assistiti), la death lineup nemmeno (sotto di 10 a rimbalzo), inconsuete distrazioni difensive. Soprattutto, il tiro dalla distanza non va a bersaglio – evento rarissimo – per la seconda serata di fila; al 33% di lunedì notte segue un modesto 38.5%

Kyrie Irving, che non sarà Tyrion Lannister ma non è nemmeno la Montagna, guadagna un comodo rimbalzo sul proprio errore
Le difese devono reggere, tuonava Gandalf alla vigilia della battaglia. Sostituite il soggetto con “le ossa della schiena di Andre Iguodala” e avrete l’esortazione su cui Steve Kerr poggia buona parte delle sue speranze.
Contro un LeBron James che ha preso la serie in mano serve il tuo miglior difensore individuale, quello che l’ha limitato efficacemente in gara 1 e 2, a costo di imbottirlo di antidolorifici con dosi equine. Non vuole rivedere la versione di gara 6, scricchiolante e costretta a cedere l’onere della marcatura a Draymond Green.
A proposito delle prime due partite della serie; i Warriors le avevano comandate nonostante lo scarso apporto degli Splash Brothers grazie a dei comprimari di lusso, gli stessi che hanno prodotto sotto le aspettative nelle ultime sconfitte.
Con gli alieni di Space Jam che hanno rubato il talento allo stesso Iguodala, Shaun Livingston e soprattutto Harrison Barnes (2/22 dal campo in gara 5 e 6, e stavolta gioca solo 16 minuti), Kerr è stato costretto a lineup sconsigliate ai minori con Leandrinho Barbosa sugli scudi. Non l’uomo a cui affideresti il tuo destino in gara 7, per quanto imprevedibili siano queste Finals.
Se c’è una nota positiva nella sconfitta di gara 6 è che non ha complicato le idee a coach Kerr. Ogni dettaglio deve migliorare, ogni giocatore deve esprimersi con più lucidità e impegno, dal supporting cast alle voci soliste.
Rise to the occasion, accettare la sfida; questo dev’essere il mantra di Draymond Green alle prese con un problema tecnico – i Cavs non gli concedono spazio per orchestrare l’attacco e lui deve trovare altri modi per essere produttivo – e soprattutto mentale.
Sembrava che il parquet di Cleveland fosse cosparso di uova a giudicare da come camminava, con la paura di un’ulteriore squalifica aveva perso il fuoco sacro, atteggiamento già visto nelle partite in Oklahoma. Un animale in gabbia, o se preferite un orso non più libero di danzare.
Ma in gara 7 non avrà più da preoccuparsi di eventuali punizioni comminate in sala video dalle eminenze grigie della lega; gli basterà non farsi buttare fuori per 48 minuti.
A proposito; Steph Curry è, a prima vista, il Warrior che esce a testa più alta da gara 6, un leader che predica nel deserto, ma i sei falli pesano sul suo curriculum più dell’esternazione di rabbia che gli è costata una doccia anticipata.
Cade a piè pari nella trappola dei Cavs, che vogliono esporne i limiti come difensore, si avventura in rischi inutili e sfida i grigi a dare aria al fischietto. Se Steve Kerr – a quanto sono arrivate le bugie? – si stupisce che l’operato di un MVP venga giudicato con tale fiscalità, deve anche aspettarsi che lo stesso MVP sia più lucido su scelte da cui dipende la vittoria di un anello.
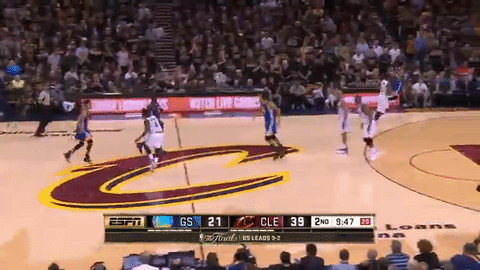
L’attacco Warriors non è andato molto più in là di questo schema: palla a Steph e viva il parroco. Per lui comunque 30 punti con 8/20 al tiro, ma anche 4 palle perse a fronte di un magro bottino di 1 assist, 1 rubata e 2 rimbalzi
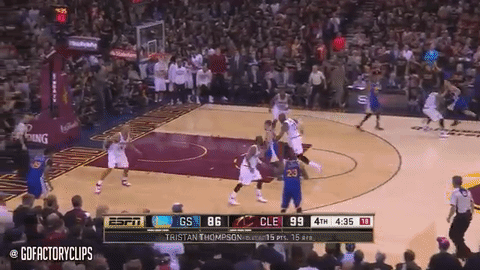
La zingarata a canestro di Curry – col taglio tardivo di Klay e un uomo che si disinteressa dell’azione – finisce con la stoppata di LeBron che ne approfitta per fargli un discorsetto. My two cents? Non gli ha illustrato il suo punto di vista sulla Critica della Ragion Pura
Gara 7, manco a dirlo, nel vespaio della Oracle Arena sarà il palcoscenico più vasto mai sperimentato da lui e dal fratello di scorribande, e non si accetterà niente di meno che una prestazione for the ages. Pure Klay Thompson non dovrà accontentarsi di giocare la partita ingrugnata a cui Cleveland spesso lo costringe, in cui litiga coi ferri prima di trovare la mira; senza nulla togliere al più blasonato collega, nella vittoria più importante della stagione dei Warriors è stato lui il protagonista.
L’adrenalina è la reazione istintiva di un vertebrato al pericolo. L’uomo non fa eccezione, i Warriors nemmeno. Con le nostre menti capaci di elaborare e proiettare eventi futuri, basta un’idea a farla scorrere a fiumi, un pensiero. L’attesa. L’adrenalina gioca col corpo e coi sentimenti. Genera rabbia.
“Play angry” ha esortato Klay Thompson, subito dopo quel win or bust. “100% angry”. Ma c’è una sottile linea che separa la rabbia dalla paura di vincere, la speranza dell’altezza dalle vertigini che ne conseguono, e c’è uno col 23 e una canotta wine & gold che aspetta soltanto di infilarsi – di forza – in quello spiraglio.
Chiamatele strane, indecifrabili, fatte di un testacoda e di un blowout dietro l’altro, ma le Finals 2016 hanno preparato il terreno per una resa dei conti tra due corazzate in perfetto equilibrio, 610 punti a testa. Game 7, signori e signori, il playground delle leggende. Cosa chiedere di più?
Scrittore e giornalista in erba – nel senso che la mia carriera è fumosa -, seguo la NBA dall’ultimo All Star Game di Michael Jordan. Ci ho messo lo stesso tempo a imparare metà delle regole del football.